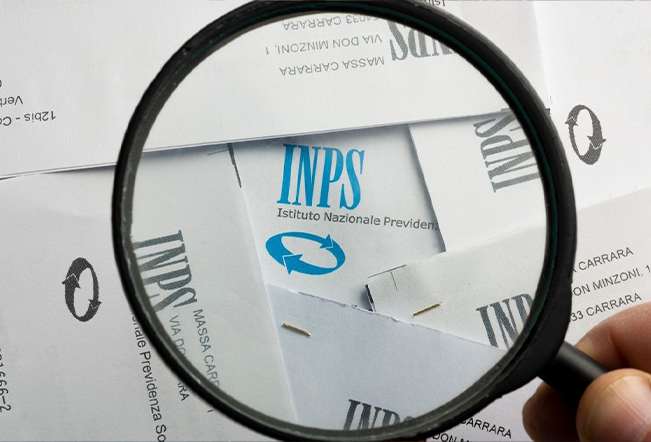Il problema non sono i vecchi, ma i giovani che non ci sono. Bisognerebbe non indulgere in un ribaltamento di prospettiva; perché non si semplificherebbe un problema complesso. Si finirebbe solo per distorcerlo. In una recente analisi si è visto che l’82% delle province italiane nel Sud del Paese registra ormai un numero superiore di pensioni, rispetto a quello dei lavoratori attivi. Troppi anziani? No, troppo pochi i giovani (e ancora meno sono i giovani che lavorano).
L’inverno demografico si è abbattuto su un Paese dove il lavoro è sempre meno apprezzato, dove ha attecchito il verbo di chi ha predicato che lavorare ormai non è più necessario: “Ci basterebbe lavorare meno e vivremmo meglio”, Beppe Grillo dixit.
Una cosa è certa: con questo trend le pensioni di tutti sono a rischio. Non solo in quelle 39 province italiane dove il rapporto tra lavoratori attivi e pensioni sta scivolando sotto l’1. Secondo quanto emerge da un recente studio sul sistema previdenziale a ripartizione (com’è quello italiano), affinché il sistema pensionistico regga è necessario mantenere un rapporto di 3 a 2. Quindi, tre lavoratori ogni due pensionati. Insomma, un rapporto attivi/pensionati di 1,5.
Il sistema previdenziale italiano non è federalista, per fortuna. La solidarietà non si ferma sui confini provinciali o regionali. La solidarietà è un orizzonte nazionale. Quindi il problema non si circoscrive alle aree dove il rapporto attivi/pensionati è più deficitario; riguarda tutti. E soprattutto i più giovani. Se non ci saranno più abbastanza lavoratori attivi, non ci saranno le risorse finanziarie per pagare le pensioni ai pensionati. Il sistema a ripartizione – il massimo della solidarietà tra generazioni e tra aree geografiche – funziona così. Ma va in tilt quando le culle si svuotano e quando il lavoro viene considerato un optional, con buona pace della nostra Costituzione, che vorrebbe questa nostra Repubblica fondata proprio sul lavoro.
In questo orizzonte a rischio è inevitabile fare una considerazione sulla massimizzazione della mutualità. Il rischio si distribuisce meglio se siamo in molti a doverlo condividere. A fronte di un Istituto della previdenza (Inps) che conta circa 16 milioni di pensionati e circa 24 milioni di lavoratori attivi iscritti (tra dipendenti, autonomi e parasubordinati) ci sono una ventina di casse previdenziali che contano complessivamente meno di 1,7 milioni di iscritti attivi (i liberi professionisti). Nessuno vuole gettare la croce sulle Casse private e privatizzate, ma difficile stupirsi che alcune di queste non riescano a tenere un saldo contributivo positivo.
Negli anni del mio impegno al vertice dell’Inps si ebbe il coraggio di compiere una integrazione colossale tra diversi Istituti che confluirono nell’Istituto: dall’Ipost, all’Enpals all’Inpdap. Ma si trattava, all’epoca, di un Inps che conservava la sua più alta vocazione di servizio per il Paese. Una enorme macchina di erogazione di prestazioni sociali (contammo circa 300 “prodotti” diversi). Col tempo, purtroppo, ha prevalso l’idea che l’Inps dovesse essere una banca dati (utilissima per carità), uno strumento per fare ricerca sociale o accademica. O per diventare consigliere del Principe.
Ricordo ancora la sottile ironia di un grande conoscitore del Paese e della macchina statale, come Giuseppe De Rita, quando durante la mia presidenza assistette alla crescita del “Grande Inps”, proprio negli anni in cui ancora aleggiava nel Paese il vento federalista. Gli sembrò un caso di studio, come ai tempi di Gianni Billia. In quegli anni avevamo un unico obiettivo manageriale: l’efficienza nell’erogazione delle prestazioni e nel controllo del diritto a riceverle. Al Palazzo parlavamo con il controllo di gestione, come in qualunque azienda, pubblica o privata.
Fonte: Libero Economia